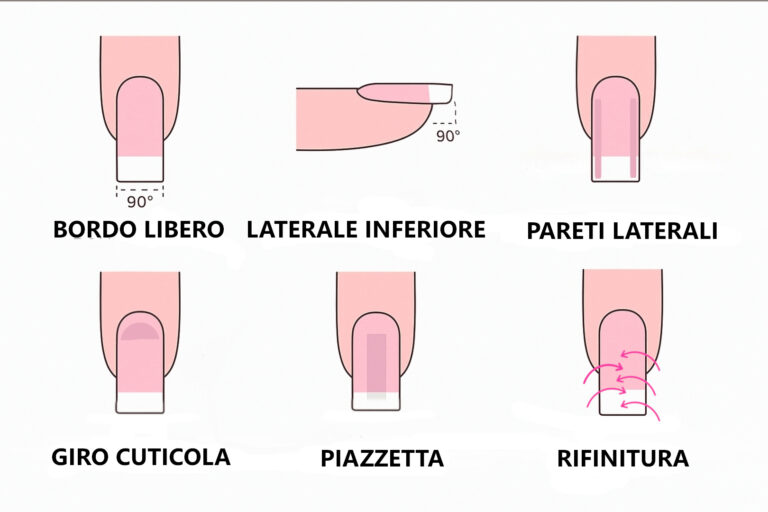Io corro. Corro sempre. Corro quando non serve. Corro quando basterebbe camminare. Corro persino quando sono in anticipo, come se volessi fottere il destino sul tempo supplementare. Ho questa specie di cortocircuito cerebrale per cui se c’è un essere umano davanti a me, anche a distanza di sicurezza, anche con un’andatura perfettamente civile, io devo superarlo. Non ho davvero fretta. Metto tra me e la realtà una quantità accettabile di asfalto. perché non mi fido del tempo. Perchè se ti fermi quello ti vede. Poi arrivo a lavoro. E allora, miracolo. Le mani rallentano. Il respiro si accoda. pensiero si siede in fondo alla stanza, e tace. Lavorare per me è l’unico modo per fermami lontano dal senso di colpa. C’è qualcosa di liturgico nel limare, nel passare lo smalto. Come mettere il mascara all’universo. In quel momento, finalmente, il mondo si ricalibra. Non c’è più il morso alla nuca del tempo, non c’è più la competizione con i pedoni, con i secondi, con i chilometri.
Solo calma.
Una calma da preghiera laica.
Una calma da confessionale illuminato al neon.
Una calma da incenso profumato di acetone.
Eppure… Lo sento. C’è qualcosa che vibra sotto la superficie. Qualcosa che rompe il sortilegio. Ed eccola li, la cliente. Che ti guarda. Con due occhi grandi e petulanti che chiedono “Quanto manca?”. Al contrario di te lei ha fretta. Non fretta di finire – no, troppo semplice. Fretta di essere altrove, di tornare al traffico, alla palestra, alla tristezza. E allora capisco che io posso anche rallentare ma il mondo no.
Il mondo ha fretta.
Anche quando non serve.
Anche quando sei già in ritardo.
Anche quando sei tu. E soprattutto:
anche quando sei cliente.